Antonello Ricci, Sguardi lontani. Fotografia ed etnografia nella prima metà del Novecento, Milano: Franco Angeli, 2023, pp. 1-240, ISBN 9788835138891
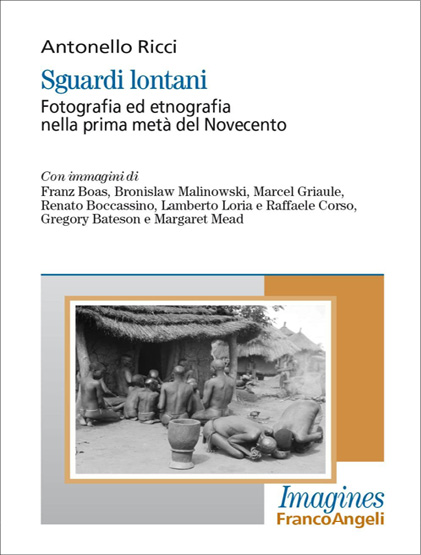
Un accurato studio di casi: è ciò che ci propone Antonello Ricci in questo suo lavoro uscito da poco che indaga il rapporto di alcuni grandi nomi dell’antropologia con l’immagine, in prima istanza con la fotografia da essi variamente impiegata e prodotta nella ricerca etnografica. Non sono certamente molti i casi di opere dedicate a questo tema1 ove si recuperano sì sguardi lontani ma resi prossimi a chi legge e si occupa di immagini grazie a un nutrito corredo di variegate e preziose fonti che disvelano la densità di approcci etnografici corroborati da pertinenti impieghi di apparecchi fotografici e cinematografici.
Questioni di forma, anzi, no, di sostanza
Questo volume tra i pregi di cui dirò ha innanzitutto quello di essere caratterizzato da una densa sequenza di fotografie, tutte debitamente accompagnate da soddisfacenti apparati didascalici e strettamente legate ai testi a cui, questi ultimi debitamente rimandano. Capita con una certa qual frequenza che accada l’opposto, che opere costruite intorno a corpus iconografici dicano di essi senza mostrarli se non mediante esigue selezioni. I motivi possono essere diversi, tra i quali costi non sostenibili dall’editore per la stampa di immagini, editoria antropologica che non contempla spazi per le foto magari con la sola presenza di qualche immagine sparpagliata nel testo: tutto questo, alla fin fine, ribadisce la preponderanza quasi assoluta della parola scritta.
Al di là della contingenza che si traduce in assenza o quasi di parti fotografiche compiute, ben organizzate e commentate, resta sovente il fatto che, quale vera e propria contraddizione in termini, l’etnografo e l’antropologo visuale discorrano di immagini senza mostrarle. Si slitta subito sul pur lodevole piano di una riflessione teorica e complessiva ove il riferimento a questo o quello scatto specifico diviene, o diverrebbe pleonastico, inutile. Parrebbe una questione di forma che però, su di un piano sostanziale, continua a indicare la supremazia dei testi sulle immagini quando i primi, surrogano le seconde delle quali dicono senza mostarle, senza pubblicarle.
Qui no: nel lavoro di Antonello Ricci le foto sono collocate, come detto, in un’unica e compatta sezione: tale compattezza segnala e ribadisce una presenza certamente non secondaria o, peggio, ancillare delle immagini nei confronti della parola scritta.
Altro aspetto rimarchevole e non frequente: le immagini sono accolte e stampate su carta patinata di apprezzabile grammatura, in grado di far risaltare i toni di foto i cui originali hanno superato, e non di poco, i cento anni. Le riproduzioni di codeste foto, scendendo nel dettaglio, paiono, tornando all’analogico, spettacolari stampe Agfa al cloro e non certo al bromuro meno capace di esaltare tonalità profonde, forti contrasti, neri caldi e densi. Si apprezza dunque una omogeneità tonale complessiva che con buona pace di fini dicitori che avrebbero da ridire sulle distanze tra originale analogico e sua riconversione digitale che ha probabilmente beneficiato di programmi di correzione dei toni, contribuisce però a rimarcare una centralità della sezione iconografica grazie proprio a questa uniformità tonale.
Sul piano dei contenuti, Ricci appronta una antologia di autori dei quali descrive e analizza il rapporto con i mezzi di ripresa audiovisiva, italiani e stranieri. In tal senso, e questo ci pare un altro aspetto rimarchevole del lavoro, non limita il discorso, come sovente accade, alla sola fotografia ma, parimenti a riprese e sequenze cinematografiche di cui non si poteva non dire dal momento che, ad esempio, nel volume, si parla, tra gli altri di Bateson e Griaule ma pure di un Boccassino rammaricato, in Uganda, negli anni Trenta, di non poter disporre di una cinepresa, di un “cinematografo” come lui lo chiama, più utile della foto nella registrazione e nella documentazione dell’intrinseca cinesi di rituali funebri.
Colpisce inoltre positivamente il fatto che l’etnografia visuale non possa e non debba rimanere circoscritta alle attività di registrazione fotografica, cinematografica e audio sul terreno. Spesso, in seno all’antropologia, il dibattito si concentra soprattutto su metodi e tecniche da definire, mettere a punto e attivare sul campo. Ricci ricorda invece che colui il quale, assieme al taccuino, accosta l’occhio alla loupe, ieri di una reflex e di una 16mm, oggi di una fotocamera o di un camcorder digitale deve successivamente prospettarsi gli esiti di una indagine che ha prodotto una documentazione visuale in linea con le caratteristiche, con gli specifici dei mezzi impiegati. In altri termini, se il taccuino sta al rapporto di ricerca più o meno sic et simpliciter, l’uso di una documentazione audiovisiva rimanda ai mezzi mediante i quali tale documentazione tradizionalmente comunica, ovvero documentari, mostre, fotolibri e, aggiungiamo noi, programmi di navigazione e consultazione interattiva, videoinstallazioni digitali2, siti e portali di natura museografica3.
L’autore riferisce, in tal senso, di una mostra dedicata all’appena citato Boccassino, già essa espressione della congruente traslazione di un corpus di foto di ridotto formato da un archivio consultato da soli addetti ai lavori a una strategia divulgativa che modifica e ingigantisce i formati per adeguarsi da un lato alle modalità di visione proprie di una esposizione e per consentire dall’altro ai visitatori di cogliere i molti dettagli presenti negli scatti. L’esperimento non si conclude qui ma va oltre sollecitando non solo la visione delle foto ma associando ad essa l’ascolto di suoni registrati da Boccassino sul campo. Ricci definisce codesto suo esperimento quale mostra multimediale ove i due canali espressivi si compenetrano, si fondono evocando, anche emotivamente, i contesti etnografici ugandesi. Ci pare codesto esperimento felice anche perché restituisce ai toni emozionali dell’evento così apparecchiato funzioni etnograficamente integrative e avvolgenti.
A un addetto ai lavori “Sguardi lontani” colpisce anche per il modo con il quale è definita e organizzata la galleria di ricercatori e studiosi “audio visuali” su cui l’opera si concentra. Siamo al cospetto di antropologi italiani ed esteri dei quali in diversi casi si trova più o meno cospicua traccia nella saggistica e nella manualistica antropologica e pure sociologica4, ma senza che di essi si indaghi e si riproponga il loro rapporto con i mezzi di indagine visuali, che invece Ricci, ribaltando la prospettiva, pone al centro della loro produzione scientifica.
Si tratta di operazione complessa perché frutto di una approfondita intersezione di fonti. Il peso che l’immagine ha avuto in questo o quello studioso, nella sua produzione etnografica, nell’ambito di riflessioni di carattere più specificamente teoriche è la risultante di uno sguardo che attualizza e acuisce codesti lontani sguardi, contestualizzandoli attentamente e anche criticamente in relazione alla formazione scientifica di ognuno dei ricercatori presi in esame, alle attività di terreno, al rapporto con altri studiosi, alla creazione di équipe composite in cui alle volte è il ricercatore a premere il pulsante di scatto, altre volte un operatore amatoriale o un professionista, in relazione alla preferenza accordata alla macchina fotografica o alla cinepresa come pure in merito agli esiti delle documentazioni visuali ed audio visuali prodotte, confluite, a seconda dei casi, in un rapporto di ricerca, in una monografia scientifica, in un volume fotografico, in una mostra e nel suo catalogo, in articoli su riviste specializzate o destinate a un pubblico più eterogeneo di lettori, a un documentario, a un corto o a un lungo metraggio, a un film. Si ha la piacevole sensazione di essere portati dietro le quinte potendo osservare da presso in qual modo un ricercatore abbia organato, a cominciare dal campo, l’impiego dell’apparecchio fotografico o cinematografico, entro quali coordinate, a quali latitudini, con quali funzioni rispetto alla metodologia e alle tecniche per così dire convenzionali.
Prendiamo, ad esempio, il caso di Marcel Griaule di cui Ricci mette in luce la complessa e alle volte contraddittoria posizione assunta dal ricercatore francese in merito agli ambiti in cui fotografare o girare, ponendosi personalmente dietro il mirino o avvalendosi di operatori dilettanti o professionali finanche di operatori con una formazione etnografica, stabilendo punti plurimi di ripresa, facendosi fautore di riprese aeree in virtù di una ricercata e olistica visione che potremmo definire come antropo-geografica. Ricci ordisce una trama di dati e documenti, di fonti bibliografiche e giornalistiche; riporta testimonianze, descrive filmati e foto disvelandone nel dettaglio le significazioni scientifiche ma pure divulgative, rammenta le relaziono con le avanguardie artistiche del primo Novecento a partire dal surrealismo non mancando di sottolineare quel “vizietto” comune a diversi ricercatori dell’epoca di edulcorare la visione di un mondo “vergine”, di esotismi incontaminati che fisicamente espungevano dall’inquadratura la presenza sempre più ingombrante di un colonialismo che era poi il primo finanziatore di missioni e ricerche antropologiche come quelle effettuate da Griaule5. Di contro Ricci segnala senza scandalizzarsene la tendenza di Griaule a far ripetere l’evento da documentare, a lasciarsi, come nel cinema, la possibilità di far replicare il “ciak si gira” più di una volta. In tal modo il ricercatore francese si garantisce la possibilità di scegliere i punti e i campi di ripresa già sapendo chi o cosa inquadrare. Questa opportunità ha fatto e fa spesso sobbalzare sulla sedia gli antropologi, in qualche modo più ortodossi, che vedono in siffatta procedura una alterazione del dato etnografico e del set che, appunto, parrebbe farsi cinematografico. Chi lavora con una telecamera ma anche con una macchina fotografica ben si sarà reso conto di quante volte avrà perso l’attimo fuggente, non avendo colto questo o quell’aspetto semplicemente perché palesatosi all’improvviso, magari fugacemente, anche inusitatamente. La richiesta di reiterare questo o quell’atto, di ripetere un’azione, un movimento coreutico, una frase, dal nostro modesto punto di vista, e mi pare pure di Ricci, non deve scandalizzare nella misura in cui, comunque la si intenda, arricchisce e completa la documentazione recuperando dei dati altrimenti destinati a essere inesorabilmente persi. Già Lamberto Loria auspicava la cosa6 e, in tempi ben più recenti, pure Ernesto de Martino scelse questa via. Nella ricerca sul tarantismo, come alcune foto di Franco Pinna [Pinna, Bruno, Domini, Olmoti 1996, 126] testimoniano inequivocabilmente, si vede interloquire lo studioso con una donna a cui chiede di scandire e mimare i passi della tarantella mentre Diego Carpitella, seduto in un angolo, è intento a osservare e trascrivere i momenti che scandiscono e caratterizzano la coreografia. Il tutto avviene nella camera dell’albergo dove è sceso l’antropologo. Qui, con maggiore agio, lontani dal clamore e dalle concitazioni del rito domestico e nella cappella di Galatina, in una condizione a tutti gli effetti da laboratorio, i due studiosi possono concentrarsi sulla performance della tarantata che, dietro un compenso, accetta di tornare a ballare “prendendo i suoni” che provengono da un grosso registratore a bobine su cui sono incise le musiche, queste sì, raccolte direttamente sul terreno7.
Tornando alle riflessioni che il lavoro di Ricci suscita in chi scrive grazie, come già detto, alla sua capacità di distendere le considerazioni in merito al peso e all’influenza che l’impiego delle documentazioni visuali hanno esercitato sugli autori considerati, in seno a una trama fitta di ulteriori dati, mi fa piacere segnalare il paziente scandaglio di fonti da cui emerge, complice la fotografia, il rapporto tra Loria e Raffaele Corso. Si apprezza il modo in cui Loria viene letto in relazione a una sua visione delle proprietà documentali della fotografia che per stessa ammissione di questo nostro infaticabile etnografo non può essere circoscritta ai dettami dell’ottocentesca antropologia fisica e delle sue tecniche di rilevazione antropometriche e craniometriche aprendo ad ambiti assai più ampi e complessi che spaziano dalla cultura materiale a quella sociale e magico-religiosa e su cui è bene che si punti l’obiettivo dell’apparecchio fotografico. La relazione inizialmente addirittura affettuosa tra Loria prossimo all’apertura della mostra di Etnografia italiana del 1911 e Corso al quale il primo chiede documentazioni di vario genere ivi compresa la realizzazione di serie fotografiche è ricostruita grazie a un sapiente incrocio di fonti, soprattutto epistolari che in certuni casi tornano utili per un certosino lavoro di identificazione di fotografi e di soggetti ritratti8.
La sensazione di essere condotti nuovamente e letteralmente dietro le quinte la si ha anche nel capitolo dedicato a Bronislaw Malinowski dove appunto si attinge ai diari di campo del padre del funzionalismo. Niente come un diario consente infatti di scostare il sipario tra dimensione pubblica e personale, tra il momento etnografico e uno più intimista e introspettivo. A ben vedere la documentazione fotografica che lo studioso accresce con frequente cadenza consente un transito tra momento scientifico e intimista. Tale pencolamento è favorito da una fotografia che come nota Ricci, si fa con Malinowski “creativa” e “immersiva” [Ricci 2023, 56] rompendo con lo schematismo di documentazioni irreggimentate, ancora negli anni Venti, da passatiste visioni antropometriche e razziali. A pieno titolo le foto del ricercatore sono riverbero di un’osservazione partecipante che, appunto, le permea. Qui, tornando ai diari, la foto giunge a eccitare un cotè decisamente emozionale, tocca le corde di un erotismo di cui il buon Bronislaw non può non dire, se pur nei protetti recinti della sua diaristica a cui ricorre, in cui si immerge e dalla quale emerge potente e prepotente un’attrazione carnale, fisica, per questa o quella giovane incontrata sul terreno e fotografata. La visione del ritratto accende l’altrettanto giovane etnologo.
Nelle sue attività di terreno agisce un approccio che definiremmo epidermico, di evidente prossimità che già solo le sue foto evidenziano chiaramente. Lo studioso appare spesso sul pezzo, del tutto interno alle situazioni che riprende, fuso in un ordito sociale e culturale che cerca di vivere, documentare, interpretare. La tessitura delle grandi vele a chela di granchio, lo svuotamento laborioso e faticoso di un albero da cui ricavare una canoa, la navigazione su codeste piroghe documentata stando a bordo, le feste che il kula accende sulle spiagge all’arrivo degli abitanti dell’isola accanto, i primi piani dedicati al momento rituale dello scambio di collane e bracciali di conchiglie, tutto, dalle pratiche quotidiane e ordinarie a quelle festive lo vede in prima fila. Più di una volta ci siamo chiesti se dietro questa centralità del Malinowski operatore, agissero in sottofondo, i mutanti criteri espressivi del nascente fotogiornalismo che dalla Germania alla Francia e poi agli Stati Uniti sdoganerà la figura del photoreporter, di quel fotografo per necessità di cose obbligato, vocato, votato a stare dentro la notizia, artefice di immagini, di testi e didascalie di accompagnamento, di sequenze queste ultime tanto care agli intenti pedagogici e narrativi delle testate che tra anni Venti e Trenta monopolizzeranno il mondo della carta stampata. In tal senso concordiamo con Ricci, quando citando Samain, rimarca la complessa rete di intrecci fra il testo scritto, le fotografie e le didascalie delle immagini che si alimentano mediante un reciproco rimando come evincibile dalle opere del ricercatore polacco, cominciando da “Argonauti”.
A questo punto pare quasi consequenziale sottolineare il legame dialogico tra testo scritto e immagine che si determina in modo ancor più evidente e strutturato nelle opere di Gregory Bateson e Margaret Mead, soprattutto nelle ricerche effettuate dai due a Bali. Il loro legame scientifico, intellettuale ma pure sentimentale, già esso poroso e spesso pannicolo su cui si distende e si intreccia una dimensione di coppia e un’attività di ricerca interstiziale, ha, secondo noi, un suo esplicito exemplum in “Caratteri Balinesi” che giustamente Ricci evoca proponendo alcune delle tavole di questa assai originale e innovativa pubblicazione. Siamo, a Bali, sottolinea Ricci, sempre attento a definire il contesto in cui si determina una etnografia visuale, al cospetto di una “ampia presenza di fenomeni di trance e di dissociazione del comportamento, diffusamente ricorrenti nella vita dei balinesi come aspetti istituzionalizzati e culturalmente previsti e non come fenomeni di disordine psichico” [Ricci 2023, 110]. La codifica di pratiche e comportamenti socialmente approvati e catechizzati che si ripresenta e sostanzia in molteplici attività, da quelle lavorative a quelle cultuali, dal lavoro nei campi, alle cure parentali, dai riti funebri alle scuole di danza trova nella fotografia lo strumento migliore per scandire e dettagliare tali procedure variamente propedeutiche alla relazione con la trance. “Caratteri balinesi”, volume di ampio formato, così concepito per accogliere una cospicua quantità di immagini, è strutturato in modo da presentare in ogni doppia pagina un tema, una prassi sociale, un’azione, un tirocinio, una procedura di inculturazione e alfabetizzazione ai culti estatici. Su una pagina è collocata una nutrita serie di immagini numerate e sull’altra un testo e, o un apparato didascalico informativo. Le due parti sono intrinsecamente legate nella definizione di una documentazione e di una comunicazione ove finalmente, parola e foto convivono alla pari e a tutto vantaggio di una maggiore chiarezza esplicativa e di un conseguente approfondimento.
Che dire, potremmo continuare parlando di altri autori che Ricci ospita nel suo volume ma preferiamo fermarmi qui ringraziando l’autore per questo viaggio in cui, a proposito di trame e legami dialogici, si giunge a cogliere un ordito in cui dimensione scientifica, cura del dettaglio, attenzione alle fonti ivi compresa un’aura empatica consentono di cogliere a tutto tondo l’articolato, complesso rapporto tra ricerca antropologica e immagine così come densamente concepito e restituito da quei padri della disciplina ai quali Antonello Ricci si è rivolto mettendone in evidenza i distinguo ma parimenti le molte assonanze, anzi, le patenti consonanze che hanno caratterizzato una ricerca in grado di cogliere le opportunità e le potenzialità euristiche e interpretative delle immagini.
Ricci, con le sottolineate attenzioni agli studiosi chiamati in causa mediante le quali irrela le procedure etnografiche classiche a quelle audio visuali, restituisce a chi codeste relazioni attiva sul terreno in una autorialità consapevole dei diversi linguaggi messi in essere, tutti tanto ponderati, anche problematizzati quanto, parimenti, verificati in seno a reciproci, fruttuosi e ingegnosi rimandi tratteggia la figura di un ricercatore che con piena consapevolezza ordisce siffatte e articolate procedure euristiche. Sono felici eccezioni in un più generale panorama antropologico, italiano e internazionale ove, come detto, la relazione tra fonti orali e visive soffre ancora e spesso di balbuzie patenti. Scrive a tal proposito Lello Mazzacane evocando le difficoltà relazionali e comunicative tra Pinna e de Martino quanto segue:
C’è la macchina fotografica a riprendere e “documentare” gli avvenimenti […] ma non c’è l’uomo dietro di essa, o meglio c’è in quanto operatore intercambiabile. Il fotografo è un tecnico, un attrezzo che ci si porta appresso alla stregua del registratore o della cinepresa, e che fa tutt’uno con essi nella loro funzione meramente riproduttiva della “realtà” osservata. […] E dunque il fotografo che fine ha fatto? È stato semplicemente un operatore tecnico che ha premuto il pulsante quando la rilevazione del dato lo richiedeva o ha auto un margine di autonomia nel suo lavoro? Il ruolo del fotografo […] è del tutto marginale [Mazzacane 1996, 125-129].
Su tale sfondo variamente sconfortante, talora ancora oggi perdurante, il lavoro di Ricci acquista dunque maggiore valore avendo individuato in alcuni padri dell’antropologia una propensione a “rivalutare” l’impiego dei mezzi di ripresa visiva.
Fin qui il passato auspicando ulteriori osservazioni sulla contemporaneità digitale
Tutto ciò detto, avendo dunque apprezzato questo approfondito lavoro dedicato, per così dire, ai classici dell’antropologia visuale, lavoro di cui si avvertiva l’esigenza, ci chiediamo però in qual modo si potrebbe parimenti aprire una finestra sulla contemporaneità, su un mondo della comunicazione oramai digitale contraddistinto da vettori “liquidi”, in continua trasformazione, dove un genere sfuma subito in un altro, dove anche i contesti di fruizione dell’immagine si moltiplicano velocemente ibridandosi. In questo magma iconico continua ad essere presente e attiva una propensione alla documentazione antropologica che però prende forme inusitate, ma soprattutto che apre le porte a una giovane galassia di sperimentatori di cui non è assolutamente facile seguire i percorsi anche a causa di un divario linguistico, comunicativo e tecnologico difficilmente colmabile. Si registra inoltre l’esplosione di certuni ambiti professionali come quello del photoreportage sociale e anche antropologico che l’epoca del digitale alimenta enormemente ma del quale si ha una conoscenza soltanto a macchia di leopardo anche perché la sua diffusione si determina ma pure si sfarina nei molti rivoli della rete. Esiste pure un ingresso femminile in professioni un tempo considerate eminentemente maschili che dischiude nuovi ambiti di indagine, letture per certi versi inusitate di cui sono autrici fotografe, cineaste, video maker con patenti sensibilità antropologiche anche esse propense a una collocazione dei loro prodotti su Internet.
Chi come noi, grazie alle professioni universitarie, ha il privilegio di mantenere un fecondo affaccio sui post millennials, altrimenti detti, con alcune differenti sfumature di significato, zoomer o anche generazione z, si rende conto, beffardamente proprio grazie a tale affaccio, di distanze comunicative che probabilmente si acuiranno sempre maggiormente. La recente pandemia, ad esempio, è stato uno straordinario brodo di coltura per modalità di comunicazione digitale del tutto nuove9, ma pure frutto di miscelazioni informatiche, cromatiche, sonore e interattive che hanno ripescato atmosfere e ambienti virtuali di un passato digitale e social recente ma al contempo già arcaico benché parzialmente riattualizzato. Ce ne hanno dato un saggio alcuni nostri studenti che sia per la giovane età che attribuisce a essi lo status di osservatori interni, loro per primi a confrontarsi con forme espressive digitali nuove, sia per la capacità dimostrata nell’attuare una prima ricognizione etnografica sulla rete, hanno indagato su di essa certune liminali e porose strategie comunicative. Nella fattispecie Andrea De Gregorio e Nicole Della Rocca hanno notato come la liminalità, già di per sé condizione ricorrente sulla rete e per paradosso anche sui social che mentre illuminano i loro utenti al contempo li ottenebrano e li emarginano, si è ulteriormente declinata quale risposta all’horror vacui di una esistenza rarefattasi a causa del covid.
Il fenomeno degli spazi liminali ha così coinvolto un’intera schiera di utenti online, su varie piattaforme quali Reddit (r/LiminalSpace con quasi seicentomila membri), Youtube, Pinterest, Instagram, a cui si sono ricollegati anche generi musicali (sottogeneri della vaporwave e della synthwave, come la dreamwave o weirdcore) ispirati alla cultura pop degli anni 80’-90’, oppure aventi legami con l’elettronica più recente come nel caso della slushwave, plumberphonics o dark ambient [De Gregorio e Della Rocca A.A. 2022-2023].
La forzosa disarticolazione delle relazioni ha spostato la comunicazione sulla rete spesso mediante strategie rappresentative che non riempivano l’assenza riconfigurandola digitalmente e disinnescandola, ma, all’opposto, attraverso un’acuita rappresentazione del vuoto stesso, di un limen tendente a esacerbare distanze lontananze, privazioni.
Si sono riaffermate, ad esempio, le backroom precedenti allo scoppio della pandemia, fenomeno Internet nato nel 2019 su 4chan attraverso la diffusione di rendering di luoghi insoliti, associati a loro configurazioni e descrizioni criptiche, claustrofobiche, misteriche, oscuri inghiottitoi digitali che hanno in qualche modo trattenuto e incapsulato al loro interno schiere di utenti. Tali tenebrose ed enigmatiche stanze si sono rapidamente e largamente diffuse in vari formati, declinandosi su Youtube come found footages, film, videogiochi. Siffatti spazi concorrono alla generazione di stati d’animo ammantati da malinconia, nostalgia, sospensione, evasione, innescando un coinvolgimento psicofisico ed emotivo dell’utente che attiva proprie modellazioni e modalità adattative secondo linguaggi atti a dialogare specificamente con codeste realtà funeree e criptate [De Gregorio e Della Rocca A.A. 2022-2023].
Dovremo tentare dunque di volgere lo sguardo anche su codeste fuggenti, transeunti e mutanti forme di rappresentazione visiva contemporanee opponendo, come giustamente nota Eugenio Zito, a un “tardivo interesse degli antropologi per i media e poi i new media” l’assunto che “nell’epoca del traffico delle culture transnazionali e delocalizzate […], la frequentazione del web consenta potenzialmente un’esperienza conoscitiva in qualche modo assimilabile a quella dell’osservazione partecipante” [Zito 2021, 92].
Dovremo attrezzarci per allungare i nostri sguardi anche su tale ribollente, multivisiva e multisensoriale attualità.
AA.VV. 1907, Istruzioni per lo studio della Colonia Eritrea, Società di Studi Geografici e Coloniali e Società di Antropologia, Etnologia e Psicologia comparata in Firenze, Firenze: Galileiana.
Baldi A. 1983, L’impiego della fotografia nell’indagine di carattere etno-antropologico all’interno del periodo coloniale italiano, «Rivista di Storia e critica della fotografia», n.5: 23-53.
1985, Paolo Mantegazza: alle origini dell’Antropologia visiva italiana, in AA.VV. Paolo Mantegazza e il suo tempo: l’origine e lo sviluppo delle Scienze antropologiche in Italia, Milano, Ars Medica Antiqua: 69-79.
2011, L’Antropologia visuale, in Signorelli A. Antropologia culturale, Milano, McGraw Hill Companies: 232-237.
2016 a, Ipse vidit: fotografia antropologica ottocentesca e possesso del mondo, «EtnoAntropologia», Vol. 4 n. 1: 3-28.
2016 b, Etno-show. Quando l’antropologia andò in scena, un’antropologia bella da vedere, «EtnoAntropologia», Vol. 4 n. 2 : 37-82.
2021, Pandemia, imago mortis e sue migrazioni digitali, «EtnoAntropologia», Vol. 9 n.1: 253-268.
Bertozzi M. 2008, Storia del documentario italiano. Immagini e culture dell’altro cinema, Venezia: Marsilio.
2018, Documentario come arte, Venezia: Marsilio.
Bignami A. 2011, Il documentario. Scrivere, realizzare e vendere cinema della realtà nell’era dell’artificio, Roma-Bari: Laterza.
Cagol S. 2019, It’s all about living and taking Energy, Tokyospace.
2020, The Time of the Flood. Beyond the myth through climate change, Milano: Postmedia.
Collier J. 1967, Visual Anthropology. Photography as Research Method, New Mexico: University of Albuquerque.
De Gregorio A., Della Rocca N. 2022-2023, Ambienti liminali e linguaggi criptici sulla rete. Una prima ricognizione, relazione redatta per la cattedra di Antropologia culturale del Dipartimento di Scienze sociali e del MAM – Museo Antropologico Multimediale dell’Università di Napoli Federico II.
Dimpflmeier F. 2020, Il giro Lungo di Lamberto Loria. Le origini papuane dell’etnografia italiana, Roma: CISU.
Ferrarotti F. 1974, Dal documento alla testimonianza. La fotografia nelle scienze sociali, Napoli: Liguori.
Giacalone F. 2021, Riflessioni al tempo del covid: relazioni cura, forme di socialità e gestione della morte. Introduzione alla sezione, «EtnoAntropologia», V.9 n.1:131-136.
Gilardi A, 1976, Storia sociale della fotografia, Milano: Feltrinelli.
Hockings P. 2003, Principles of Visual Anthropology, Montage Court - San Jose: Mouton.
Lasagni M. C. 2014, Nanook cammina ancora. Il cinema documentario: storia e teoria, Milano: Mondadori.
Loria L. 1907, Come si deve usare la macchina fotografica in AA.VV. Istruzioni per lo studio della Colonia Eritrea, Società di Studi Geografici e Coloniali e Società di Antropologia, Etnologia e Psicologia comparata in Firenze, Firenze, Galileiana: 10-13.
Mattioli F. 2015, La sociologia visuale. Che cosa è, come si fa, Acireale - Roma: Bonanno.
Mazzacane L. 1996, Pinna e De Martino: una vicenda complessa, in Pinna G., Bruno M.S., Domini C., Olmoti G. (eds) 1996, Franco Pinna. Fotografie 1944 -1977, Milano, Motta: 125 -135.
Pennacini C. 2023, Filmare le culture. Un’introduzione all’Antropologia visuale, Roma: Carocci.
Perna R., I. Schiaffini (eds.) 2015, Etica e fotografia. Potere, ideologia, violenza dell’immagine fotografica, Roma: DeriveApprodi.
Pinna G., Bruno M.S., Domini C., Olmoti G. (eds.) 1996, Franco Pinna. Fotografie 1944 - 1977, Milano: Motta.
Ricci A. 2015, Su etica, fotografia, ricerca sul campo, etnografia in Perna R., I. Schiaffini (eds.), Etica e fotografia. Potere, ideologia, violenza dell’immagine fotografica, Roma:DeriveApprodi: 28-41.
2023, Sguardi lontani. Fotografia ed etnografia nella prima metà del Novecento, Milano: Franco Angeli.
Signorelli A. 2011, Antropologia culturale, Milano: McGraw Hill Companies.
Sisto D. 2018, La morte si fa social. Immortalità, memoria e lutto nell’epoca della cultura digitale, Torino: Bollati Boringhieri.
2020, Ricordati di me. La rivoluzione digitale tra memoria e oblio, Torino: Bollati Boringhieri.
Zannier I. 1979, 70 anni di fotografia in Italia, Modena: Punto e Virgola.
Zito E. 2021, «Mi fai fare un giro con la webcam?» Storie di malattia da una etnografia digitale in Marocco, «EtnoAntropologia», Vol. 9 n. 2, 91-113.
1 Ricordiamo qui, tra gli altri, i lavori incentrati sulla fotografia ma più spesso sulla documentaristica, di Bertozzi [2008, 2018], Bignami [2011], Collier [1967], Hockings [2003], Lasagni [2014], Pennacini [2023], Ricci [2015] e di chi scrive [Baldi, 1983, 1985, 2011, 2016 a, 2016 b, 2021] segnalando che in molti casi un interesse per foto e antropologia si riscontra in significativi contributi firmati da storici della fotografia tra i quali Gilardi [1976] e pubblicati, per quanto riguarda la situazione italiana da testate quali «Popular Photography Italiana», «Fotografare», «Quaderni di Storia e critica della fotografia», «Progresso fotografico».
2 Citiamo a titolo esemplificativo il laboratorio audio visuale da molti anni presente nell’offerta didattica e formativa del Dipartimento di Scienze Sociali della Federico II che, nel corrente anno accademico, ha operato una decisa sterzata voluta da chi scrive, ove il sostrato stricto sensu antropologico è stato coniugato in rapporto ai linguaggi della rete, e a rivisitazioni del dato etnografico da parte di video artisti con spiccata sensibilità per tematiche di natura culturale e sociale. Grazie a Elisia Laraia che lo dirige, di concerto con il sottoscritto, si sono volute dunque esplorare nuove latitudini, tutte rese possibili dalle opportunità del digitale, che si sostanziano in prodotti multimediali, soprattutto in video istallazioni di diversa natura ma che conservano, privilegiandola, un’ottica antropologica.
3 Ci permettiamo qui di proporre, nel suo piccolo, l’esempio del MAM - Museo Antropologico Multimediale, attualmente primo ed unico museo in veste soltanto digitale dell’Università di Napoli Federico II da noi progettato e messo in opera. Organizzato in molteplici e distinti percorsi introduce nelle teche audio visuali frutto delle campagne di ricerca degli afferenti alla struttura facenti parte, al contempo, quali docenti MDEA, del Dipartimento di Scienze Sociali. Non solo docenti ma pure dottoresse di ricerca sempre di area antropologica. In tale museo confluiscono i materiali audio visuali che già furono del Centro Interdipartimentale di ricerca audiovisiva per lo studio della cultura popolare, sempre della Federico II, struttura fortemente voluta da Lello Mazzacane e di cui il MAM è specifico erede. I menzionati percorsi tematici, tra cui quelli sulle stampe popolari, sulle edicole votive, sul teatro di figura meridionale, sulle antropologie dell’Est, sulle culture alieutiche e marinare sono tutti contraddistinti da testi, apparati bibliografici, sequenze in slide show, medio metraggi, ricostruzioni digitali in 3D che arricchiscono e ritmano la comunicazione. Si tratta di vetrine che hanno il compito di segnalare i ben più copiosi e densi archivi custoditi dal MAM.
4 Ricordiamo qui il contributo in qualche modo pionieristico di Franco Ferrarotti che negli anni Settanta del Novecento nei fatti sdoganava l’uso della fotografia nella ricerca sociale [Ferrarotti 1974] e in tempi assai più recenti di Francsco Mattioli autore di un manuale di sociologia visuale che ha conosciuto più edizioni e nel quale molti sono i riferimenti a sociologi e antropologi che sperimentarono e sperimentano l’impiego di fotografia e cinematografia [Mattioli 2015].
5 Quando non erano istanze coloniali a dover essere dissimulate, agiva un urgent anthropology che suggeriva ai ricercatori di ricomporre quadretti “idillici” in cui le popolazioni tradizionali oggetto di documentazione dovevano essere riprese come effettivamente e soltanto “tradizionali”. È ben noto l’agire di Robert Flaherty che nel suo celeberrimo documentario Nanook of the North ha cura di filmare le scene di caccia degli Inuit chiedendo loro di rinunciare ai fucili e tornare, per il tempo necessario alle riprese, all’arpione di un tempo [Mattioli 2015, 69]. “Nanook of the North riassume uno dei paradossi che attraversa l’intera storia dell’antropologi visiva. Se infatti da un lato è il primo film a fornire un vivido documento della vita di una popolazione ripresa in loco, dall’altro esso non può che avvalersi, per fare ciò, dei procedimenti tecnici e degli espedienti espressivi e retorici – dei “trucchi” – tipici del linguaggio cinematografico” [Pennacini 2023, 79].
6 In più di una occasione Loria, nella stesura di sintetici contributi di natura operativa, tecnica ed etnografica, consapevole della delicatezza delle procedure fotografiche di ripresa e sviluppo, da effettuare ipso facto sul terreno, raccomanda una quotidiana permanenza in camera oscura, o meglio nella tenda ove alla meglio disporre bacinelle e reagenti chimici per viluppare le lastre. In tale quadro “sarà bene di sviluppare giornalmente le lastre esposte ottenendo così di potere riprodurre nuovamente i soggetti che non fossero ben riesciti e di assicurare il proprio lavoro” [Loria 1907, 12].
7 Più di una volta Amalia Signorelli, tornando a parlare della sua esperienza professionale e umana con De Martino, sovente nella sua abitazione napoletana in via Girardi, al termine di una delle tante cene di lavoro, indulgeva in aneddoti e considerazioni personali molto utili per meglio comprendere come il terreno fosse un momento da affrontare sia facendosi guidare da una metodologia accuratamente messa a punto a monte, ma, parimenti, da fuoriprogramma che occorreva inventarsi lì per lì per meglio cogliere aspetti messi a fuoco solo parzialmente. Tra tali fuoriprogramma la studiosa amava ritornare al citato episodio dell’informatrice prezzolata ritenendo la mossa di de Martino e Carpitella assolutamente indispensabile per stigmatizzare quei registri, quelle manifestazione del tarantismo che necessitavano di essere enucleati dal magmatico amalgama del divenire del rituale al fine di essere soppesati e tratteggiati con maggiore precisione.
8 Fabiana Dimpflmeier mette bene in luce la complessità della pratica etnografica voluta e applicata da Lamberto Loria che mostra di tenere in particolare conto un modus operandi articolato e soprattutto integrato [Dimpflmeier 2020, 193].
9 Segnaliamo ad esempio in qual modo il covid, con il suo grave fardello di morti inizialmente assolutamente inevitabili, non circoscrivibili, in ultimo neppure metabolizzabili da chi è sopravvissuto, impedendo ai superstiti finanche di aggrapparsi a un cordoglio già esso da tempo eroso dall’incapacità occidentale e contemporanea di elaborare il trapasso, ha però innescato nuove e inusitate pratiche funebri interamente traslate su Internet. L’assenza è stata surrogata dalla digitalizzazione della morte, da ambientazioni cimiteriali e dalla interazione con gli avatar dei defunti [Baldi 2021, 253-268; Giacalone 2021, 131-136; Sisto 2018, 2020].